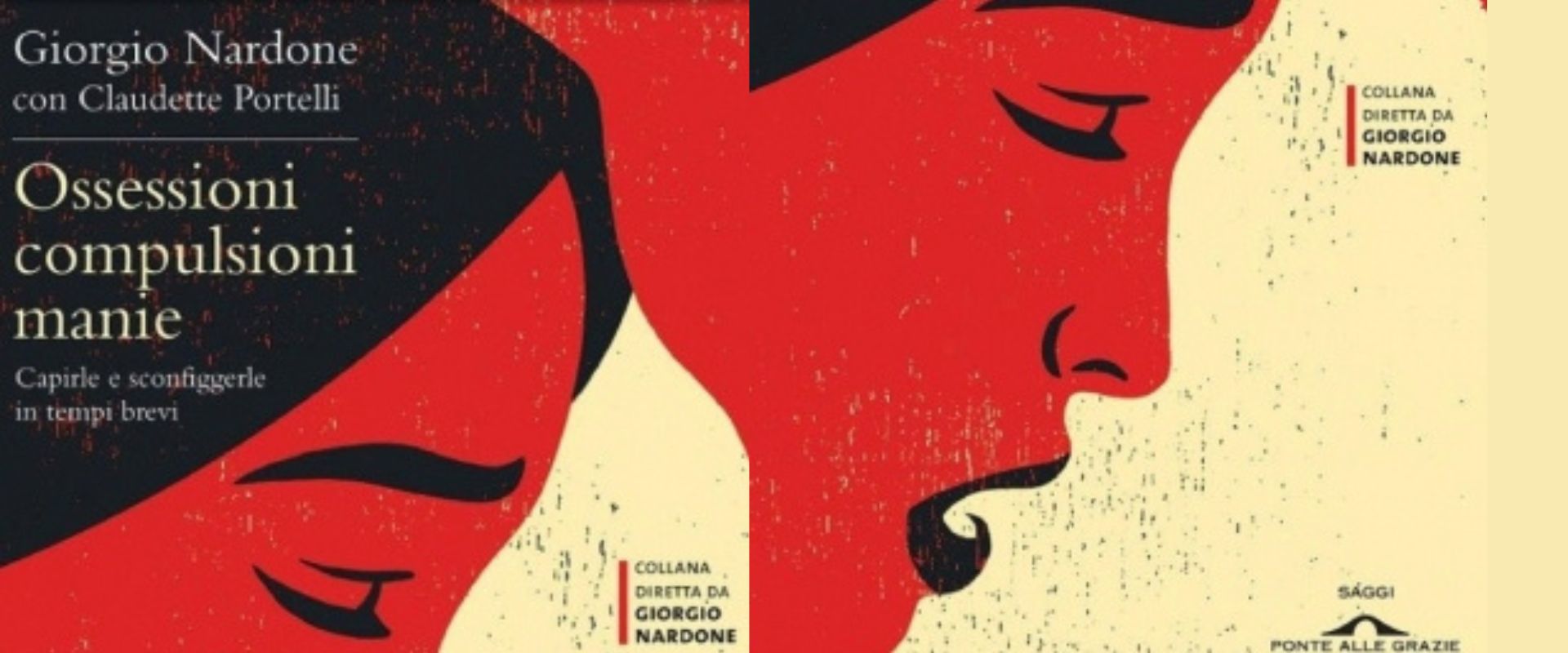“Prima di convincere l’intelletto occorre toccare e predisporre il cuore”
Quest’aforisma di Blaise Pascal racchiude, a mio avviso, una delle più potenti funzioni del comunicare, ovvero l’arte di utilizzare il linguaggio come strumento per rendere la nostra comunicazione capace non solo di far capire razionalmente e spiegare ma soprattutto di far sentire suggestivamente, come accade in una composizione musicale dove la mano del pianista che sfiora i tasti fa vibrare le corde della nostra anima.
Se il significato latino originario del verbo comunicare vuol dire “mettere in comune”, ne possiamo dedurre che l’atto comunicativo non si limita semplicemente al parlare, ma produce come effetto uno scambio, una condivisione di pensieri e sensazioni, quindi una relazione.
Questo scambio può avvenire attraverso tre livelli comunicativi: il verbale, che indica ciò che si dice e coincide con il linguaggio scritto o orale, regolato da specifiche regole sintattiche e grammaticali.
Attraverso il livello non verbale, che ricorre a canali alternativi alle parole: la postura, lo sguardo, i gesti, l’aspetto estetico.
E’ proprio al linguaggio non verbale che viene attribuito il 70% del valore della comunicazione in base alle peculiari funzioni che possiede questo canale. Quali?
Una fra tutte, l’espressione e la comunicazione del nostro vissuto emotivo attraverso la nostra postura, o le espressioni del volto.
“Non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo, una volta che si è imparato a leggerlo” scriveva Alexander Lowen.
Se il messaggio che passa attraverso la CNV (Comunicazione Non Verbale) è coerente ed armonioso con quello riportato dal verbale, il nostro messaggio verrà confermato e ne risulterà rinforzato, cioè si conferirà congruenza al messaggio.
Oltre al linguaggio verbale e non verbale, uno scambio comunicativo può avvenire attraverso l’ultimo livello ma non meno importante, il para-verbale, che non si riferisce a ciò che dico (cosa) piuttosto al modo nel quale lo dico (come). Inerente, soprattutto, alla voce (tono, ritmo, volume), alla velocità con la quale si parla (eventuali pause, o il silenzio) e ancora al timbro vocale.
A questi ultimi due canali, il non verbale ed il para-verbale è stata riconosciuta la responsabilità nell’ invio di messaggi inconsapevoli, di natura emotiva più che razionale e che sfuggono talvolta al controllo volontario.
Approfondire le caratteristiche di questi tre livelli della comunicazione ci consente adesso di affacciarci, in maniera più consapevole, al mondo della comunicazione efficace e alle sue caratteristiche.
La tecnica della comunicazione strategica, è stata estrapolata e studiata dapprima in ambito clinico all’interno della terapia breve strategica, attraverso il maestoso lavoro compiuto da Paul Watzlawick e da Giorgio Nardone, che insieme hanno fondato, nel 1987, il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.
Chi desidera esplorare l’ambito della comunicazione strategica ed imparare l’arte del dialogare in maniera efficace, dovrà imparare a danzare flessibilmente attraverso questi tre livelli della comunicazione: verbale, non verbale e para-verbale, adattandosi al contesto, all’interlocutore e allo scopo della comunicazione.
“Come l’ acqua che vince su tutto perché si adatta a tutto” , adattandosi strategicamente alle diverse circostanze.
Questa è la premessa per poter realizzare lo scopo del comunicare in maniera strategica, non solo far capire razionalmente ma soprattutto far sentire emozionalmente il messaggio.
Alla luce di quanto esposto finora, appare chiaro quanto la comunicazione strategica non si esaurisca con la fine di un atto comunicativo, ma sia in grado, andando oltre le parole, di innescare una serie di meccanismi a catena, come una palla di neve lanciata che rotola e i cui effetti continuano a lavorare nel tempo e nella mente dell’interlocutore, anche a conclusione dello scambio comunicativo.
Che io sia un terapeuta o un manager o un giornalista, riuscire ad utilizzare competenze comunicative in grado di suggestionare l’altro, appare come uno strumento fondamentale nell’ ottica di incrementare l’efficacia del mio lavoro.
Ecco perché da sempre e in diversi contesti, si è cercato di capire come poter utilizzare al massimo il potenziale di questo strumento.
Se nelle religioni lo scopo di un certo tipo di comunicazione è quello di attrarre i fedeli, nella tradizione politica ad esempio lo scopo è sempre stato quello di trovare consenso tra l’elettorato.
Oppure nel marketing e nella pubblicità, settori che da sempre si sono occupati di comunicazione, attribuendole un ruolo fondamentale rispetto ai suoi scopi.
Nella pubblicità ritroviamo tipici elementi della comunicazione persuasiva, che mirano deliberatamente ad influenzare conoscenze, valutazioni, atteggiamenti, comportamenti in determinate aree dell’attività umana, rispetto alla promozione o vendita di un prodotto o servizio.
Facciamo un passo in dietro per farne due in avanti
Scopriamo adesso chi ci ha lasciato in eredità questo tipo di conoscenze, che abbiamo potuto applicare poi nei diversi ambiti, in parte esplorati insieme.
Ci troviamo alla fine del V secolo. a. C., nel periodo in cui visse il più grande esponente tra i sofisti dell’antica Grecia, Protagora; il primo ad utilizzare l’efficacia persuasiva del linguaggio, attraverso la sua “arte del disputare”, per persuadere l’interlocutore della propria tesi.
La sua era un’arte caratterizzata dal fare domande anziché proporre affermazioni, domande strutturate in una ben precisa successione in modo da indurre risposte nell’interlocutore verso la direzione immaginata dal persuasore.
Protagora non contrastava il punto di vista del suo interlocutore bensì lo guidava, attraverso risposte da lui stesso fornite alle domande, a scoprire delle immagini alternative della realtà.
Con il proseguire degli studi di Protagora, si approfondisce la metafora e la forma aforistica, che rappresentano l’espressione più efficace del linguaggio evocativo.
A differenza della metafora, che evoca ma lascia libero l’interlocutore di costruire un significato e di interpretarla soggettivamente, l’aforisma bilanciando effetti analogici e logici del linguaggio, inchioda ad un effetto deliberato, penetrando come la lama affilata di un bisturi che taglia e provoca effetti straordinari e pianificati.
Alla retorica di Protagora, dove l’unico scopo è persuadere il proprio interlocutore, si contrappone la dialettica di Socrate, dove il dialogo è invece orientato alla ricerca della verità.
Il metodo di indagine di Socrate, basato sulla ragione, lascia una traccia importante in tutto l’Occidente.
Socrate riprende sì le tecniche della retorica di Protagora ma le trasforma in strumento di ricerca della verità. La dialettica diventa per l’uomo il mezzo per conoscere se stesso e la realtà che lo circonda.
Procedendo nel nostro continuum storico, arriviamo al contributo di Aristotele, allievo di Platone. Ad Aristotele si riconosce il merito di aver individuato una serie di tecniche di comunicazione sofistiche. E’ della sua penna l’aforisma “se vuoi persuadere qualcuno fallo attraverso le sue stesse argomentazioni”.
Arriviamo adesso all’epoca delle università medioevali. In questo periodo si deve al movimento filosofico della Scolastica, la filosofia cristiana medioevale, la ricerca della conoscenza e la difesa della verità attraverso l’uso della ragione.
Nascono diverse strategie retoriche, tra queste il dialogo che diventa lo strumento per condurre l’uomo a far propria la verità rivelata attraverso le sacre scritture.
Nei secoli a seguire tutte le più grandi scoperte vengono presentate sotto forma di dialoghi tra persone immaginarie che discutono di un argomento. Basti ricordare la presentazione della teoria della relatività che Einstein espone sotto forma di dialogo con il lettore
Questo è il panorama storico all’interno del quale si è evoluta l’arte dell’eloquenza e della persuasione. Da Aristotele in poi non possiamo contare ulteriori grandi innovazioni, sino alla nascita di una nuova scienza sociale: la psicologia.
La Ricerca Scientifica nell’ambito dello studio del linguaggio
In Occidente, a distanza di più di 2000 anni dalla grande tradizione dei sofisti, nel campo proprio della psicologia matura un forte interesse verso lo studio della comunicazione, ritenuta fondamento per costruire la propria realtà personale, interpersonale e sociale.
“Le parole in origine erano magiche” affermava Freud ed è proprio grazie a lui che nasce il dialogo psicoanalitico.
Ma già qualche tempo prima, attraverso il lavoro di Bacone, Locke e James, ritenuti i fondatori della moderna psicologia, il dialogo inizia ad essere valutato non solo come strumento che consente uno scambio comunicativo tra due persone, ma anche mezzo che veicola cambiamento e conoscenza.
Più tardi, in risposta alla dottrina psicoanalitica, fervono in questo panorama le ricerche di Milton Erickson e Carl Rogers.
A M. Erickson (1901-1980) attribuiamo il merito degli studi sull’ipnosi ed il linguaggio ipnotico oltre ad una attività di sistematizzazione di tecniche di comunicazione suggestiva all’interno del dialogo terapeutico.
A C. Rogers (1902-1987) l’individuazione di un modello di comunicazione clinica finalizzata a creare empatia attraverso una specifica tecnica di rispecchiamento, da lui definita il mirroring.
In parallelo, in questo periodo, prendono campo anche gli studi sulla linguistica grazie ai contributi di A J. L. Austin (1911-1960), noto filosofo e linguista inglese, al quale attribuiamo il merito di aver definito due grandi aree rispetto al linguaggio: – il linguaggio indicativo, che include forme di comunicazione che hanno come scopo una conduzione di informazioni-spiegazioni. E il linguaggio performativo, ovvero forme di comunicazione che evocano o inducono sensazioni, che producono a loro volta effetti.
Quest’ ultimo è un tipo di linguaggio che fa sentire e qui l’accento è posto proprio sull’aspetto pragmatico della comunicazione.
Le strategie di persuasione fanno ricorso soprattutto a questo tipo di linguaggio che, insieme al linguaggio indicativo e con l’aggiunta di espressioni suggestive, non verbali o para-verbali, diventa un potente strumento persuasorio.
I risultati di questi studi nel campo della linguistica, congiunti al lavoro di ricerca dell’antropologo e psicologo Gregory Bateson (1904-1980), condussero alla nascita di nuove teorie e applicazioni in campi trasversali tra loro: nel campo della semiotica (disciplina che studia i segni), della linguistica (disciplina che studia il linguaggio), della cibernetica.
In questi anni sarà proprio G. Bateson a dare alla luce il primo studio sugli effetti della comunicazione, non solo semantici (dal punto di vista del significato) ma soprattutto pragmatici, ovvero di come l’utilizzo strategico del linguaggio possa produrre cambiamenti nella percezione delle persone. E’ attraverso questa evoluzione di studi e ricerche, in particolare attraverso i contributi di Bateson e i suoi approfondimenti nel campo della cibernetica – secondo la quale ad ogni scambio comunicativo corrisponde una retroazione – e nel campo dell’approccio sistemico alla terapia familiare, che viene ispirato il proficuo lavoro del gruppo di ricerca californiano del Mental Research Institute di Palo Alto.
Paul Watzlawick (1921-2007), rappresenta il Maestro che più di ogni altro ha incarnato e divulgato questa tradizione in tutto il mondo.
Il suo lavoro, congiunto alle ricerche di Don D. Jackson e del gruppo di Bateson, lo ha condotto ad approfondire lo studio della pragmatica della comunicazione umana.
Il frutto di questa fervida opera di ricerca sboccia nel 1967, anno in cui P. Watzlawick insieme a J. H. Beavin e D.D. Jackson pubblica la ‹‹Pragmatica della Comunicazione Umana››, che racchiude i risultati delle scoperte nel campo della filosofia della scienza applicati allo studio del comportamento umano.
Le ricerche del gruppo di Palo Alto segnano una svolta epocale dando il via ad una nuova stagione per lo studio del linguaggio e dei suoi effetti, soprattutto se consideriamo che fino a questo periodo gli studi si erano occupati prevalentemente di struttura e significato del linguaggio.
“Non è possibile non comunicare”, recita il primo assioma della ‹‹Pragmatica della Comunicazione Umana›› di P. Watzlawick (Watzlawick, 1967), da ciò possiamo dedurre che la comunicazione costituisce una condizione imprescindibile dell’esistenza umana per cui tutte le situazioni definite interpersonali tra due o più persone risultano comunicative.
Ma se è vero che non è possibile non comunicare, dunque si può scegliere se farlo in modo strategico per poter orientare e gestire la comunicazione in modo efficace, verso uno scopo specifico, anziché in modo casuale per poi subirne gli effetti.
Negli anni ’80 P. Watzlawick pubblica un testo che rappresenta un successivo passaggio importante, Il linguaggio del cambiamento dove studia e approfondisce ulteriori proprietà di influenzamento di alcune tipologie di comunicazione attraverso l’analisi di una serie di tecniche di persuasione in grado di modificare le percezioni degli individui, quindi le loro azioni e opinioni.
Dalla metà degli anni ’80 in poi, sarà Giorgio Nardone, prima allievo e poi collaboratore a amico di P. Watzlawick ad occuparsi di sviluppare ulteriormente la pragmatica della comunicazione ed il linguaggio del cambiamento attraverso una ricerca-intervento (ormai ventennale) applicata inizialmente al campo della psicoterapia, estesa in seguito anche in ambito manageriale, in ambito giuridico e nel campo della performance sia artistica che sportiva.
I frutti di questo lavoro sono rappresentati dalla formulazione di un modello evoluto di comunicazione strategica, che raccoglie l’eredità delle antiche forme della retorica della persuasione che abbiamo attraversato prima nel nostro panorama storico, integrandole con il moderno problem solving e i contributi di altre discipline come l’ipnosi o le moderne neuro-scienze, che studiano il linguaggio come strumento di cambiamento.
All’interno della comunicazione strategica, è stata elaborata una ulteriore tecnica, frutto di un lungo percorso di ricerca e applicazione in ambito clinico e manageriale, realizzata nell’arco di un ventennio all’interno del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, ‹‹il dialogo strategico›› (Nardone, Salvini, 2005).
Questa tecnologia, utilizzata oggi per condurre un singolo colloquio, si è mostrata efficace nell’ indurre radicali cambiamenti nella rappresentazione della realtà del nostro interlocutore, in diversi contesti di applicazione non solo clinico ma anche manageriale, educativo, sportivo.
Attraverso il dialogo strategico l’interlocutore viene persuaso rispetto a quanto lui stesso scopre e sente durante il dialogo, per cui il cambiamento risulta il frutto di una scoperta congiunta priva di qualsiasi forzatura, attraverso un dialogo realizzato in maniera strategica
Come scriveva già Epicuro “non bisogna fare violenza alla natura ma persuaderla”.
Attraverso la messa a punto di questa tecnica, le domande si sono trasformate da domande aperte a domande ad illusione di alternativa, le parafrasi sono diventate maggiormente ristrutturanti, il linguaggio in grado di evocare maggiori sensazioni.
L’evoluzione di questa incessante ricerca ha permesso di individuare all’interno della comunicazione persuasiva alcune componenti caratteristiche, tra queste: la capacità di ingiungere, troviamo un esempio nelle parole di Buddha “viviamo nella paura…ed è così che non viviamo” , dove si induce dolcemente l’altro a fare esperienze che modificheranno le sue percezioni.
La capacità di evocare, come nell’aforisma di Pessoa “porto addosso le ferite delle battaglie che ho evitato”; dove siamo di fronte ad un linguaggio che ci proietta all’interno di immagini che creano sensazioni.
E ancora, la capacità di ristrutturare: intesa come effetto di un dialogo che conduce a modificare il proprio punto di vista, quindi ristrutturare le proprie visioni.
Nel concludere la nostra panoramica sui risultati delle ricerche scientifiche nell’ ambito della comunicazione, aggiungo che gli studi di psicologia sociale, insieme a quelli sulle tecniche di comunicazione e i contributi nel campo della linguistica, hanno portato ad individuare che la maggior parte della comunicazione può essere ricondotta ad un gioco di persuasione, caratteristica intrinseca della comunicazione strategica.
Giunti quasi alla fine di questo nostro viaggio all’interno degli effetti “magici” della comunicazione, permettetemi di riassumere quanto detto fin’ora.
Nel descrivervi, in modo sicuramente non del tutto esaustivo e completo un argomento così vasto, echeggiavano nella mia mente le parole di Clarke, uno dei massimi studiosi del MIT (Massachusetts Institute of Technology) “una tecnologia abbastanza evoluta non è dissimile da una magia”.
La comunicazione strategica e le tecniche evolute di dialogo persuasorio ci mostrano che quando la tecnica diventa molto raffinata i suoi effetti concreti non sono così dissimili da una magia.
Attraverso un tuffo nell’ antica tradizione dell’arte retorica ellenica e della Scolastica medioevale, abbiamo rintracciato le radici storiche e culturali dell’antica e nobile arte della comunicazione strategica e della persuasione.
Tutta l’opera dei sofisti ruota attorno all’ idea che il nostro linguaggio crei la realtà con la quale interagiamo; per usare le parole di Ludwig Wittgenstein “la realtà è il frutto del linguaggio che usiamo per descriverla”. Quest’aforisma è già sufficiente per evidenziare l’importanza del comunicare in maniera efficace e strategica in ogni ambito.
Rispetto ai contributi scientifici e di ricerca abbiamo sottolineato la svolta epocale segnata dalla tradizione degli studi della Scuola di Palo Alto, che rifacendosi proprio all’antica tradizione dei Sofisti, ha segnato l’inizio di una nuova metodologia per lo studio e l’intervento sugli individui, legata al costrutto di base secondo il quale la comunicazione “costruisce” la realtà.
Ed è con il primo postulato della pragmatica della comunicazione – non si può non comunicare – che nasce l’approccio strategico, cioè l’applicazione alla comunicazione interpersonale delle formulazioni sia teoriche che applicative del gruppo di Palo Alto.
Inizialmente, in ambito psicoterapeutico, attraverso la cura dei disturbi psicologici, per poi generalizzarsi anche ad altri contesti non specificatamente clinici, il contributo del gruppo di ricerca del MRI rappresenta l’inizio di un nuovo modo di intendere il cambiamento, che va prima di tutto agito ed in questo senso la comunicazione terapeutica ne rappresenta il veicolo.
In terapia strategica, la comunicazione si trasforma in comunicazione strategica, grazie all’uso di ingiunzioni, suggestioni, retorica della persuasione e stratagemmi comunicativi, che aggirano i sistemi rappresentazionali della persona, e quindi la naturale resistenza per mantenere la sua omeostasi, e veicolano il cambiamento guidando la persona a costruire nuove percezioni. Di conseguenza cognizioni e poi azioni alternative.
La ricerca scientifica sulla comunicazione è molto vasta ma solo in pochi e tra questi i ricercatori del Centro di Terapia Strategica di Arezzo guidati da Giorgio Nardone, hanno realmente prodotto dei contributi che si riferiscano a strategie comunicative evolute, che siano replicabili e trasmissibili e quindi applicabili da chiunque desideri apprendere tecniche evolute per operare il cambiamento.
“E alla fine del viaggio ci troveremo al punto di partenza” scriveva T.S. Eliot
Permettetemi di concludere con un aforisma di Cicerone che racchiude a mio avviso l’anima di quanto detto finora: “l’ottimo oratore è colui che parlando istruisce, diletta e al tempo stesso commuove l’anima dei suoi ascoltatori”.
Fonti bibliografiche:
“Pragmatica della comunicazione umana”. P. Watzlawick, J.H. Beavin, D. D. Jackson. Casa editrice astrolabio, 1967.
“Il linguaggio del cambiamento”. P. Watzlawick. Editore Feltrinelli, 1980
“Il dialogo strategico”. G. Nardone, A. Salvini. Ponte alle grazie, 2005
“Cambiare occhi, toccare il cuore”. G. Nardone. Ponte alle grazie, 2007
“Solcare il mare all’insaputa del cielo”. G. Nardone, E. Balbi. Ed. Ponte alle grazie, 2008.
“La nobile arte della persuasione”. G. Nardone. Ponte alle grazie, 2015