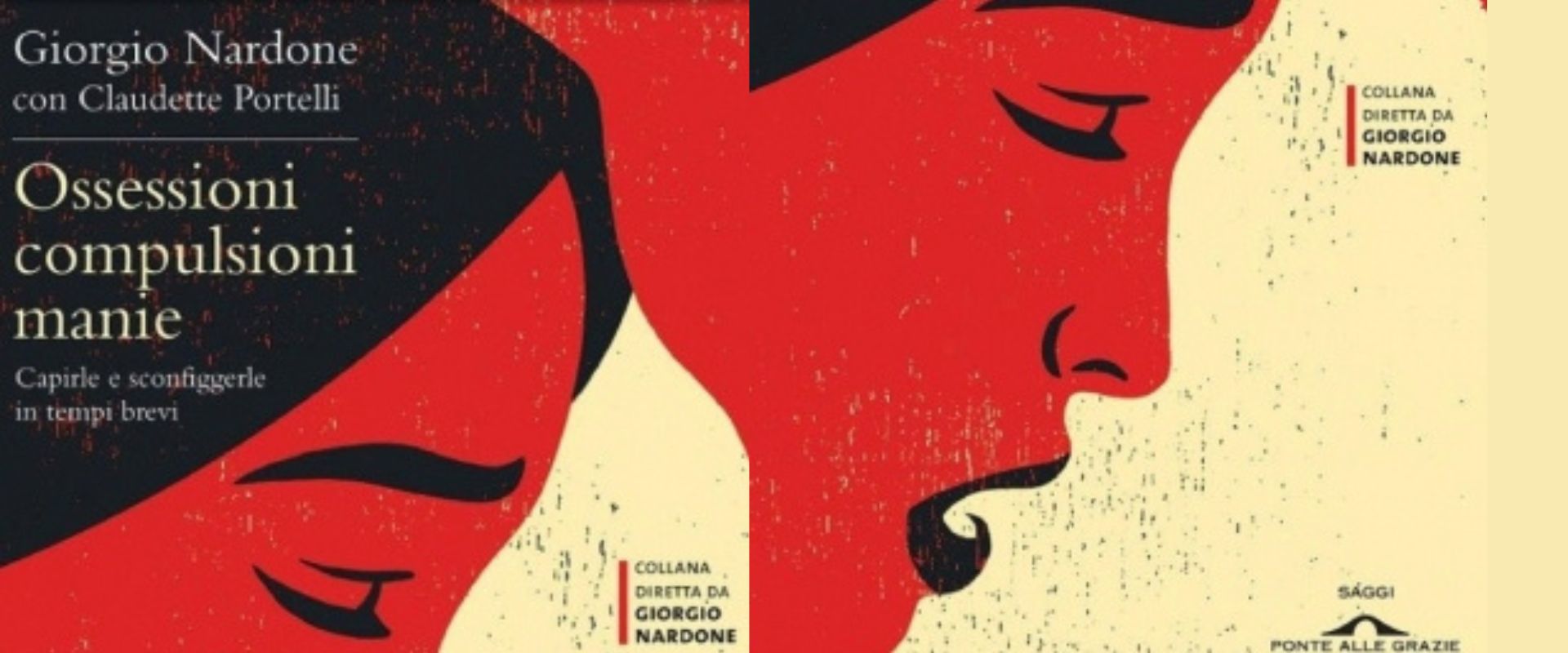Insieme al neonato nascono anche due genitori o forse sarebbe il caso di dire “presunti tali”, nel senso che l’essere genitori è un work in progress, lo si diventa piano piano a piccoli passi tra difficoltà, errori, successi, soddisfazione, frustrazioni.
Forse qualcuno di voi avrà sentito qualche volta il termine “transazione alla genitorialità”: rappresenta quel complesso e delicato processo che conduce una coppia a diventare una coppia genitoriale.
Questa transazione porta con sé una crisi che però non è necessariamente sinonimo di problema o condizione patologica, ma è sinonimo di cambiamento e il cambiamento in genere implica sia possibilità che rischi.
Quali sono i fattori che possono intervenire nella scelta di avere un figlio?
Direi in primo luogo fattori personali, primo fra tutti il desiderio di maternità e di paternità, il livello di maturità che uomo o donna sentono di aver raggiunto per potersi prendere cura di un bambino.
In particolare nel caso della donna, alcune ricerche hanno individuato alcuni precisi fattori che influiscono sulla decisione di avere un figlio: oltre ad una sicurezza economica e professionale, l’età biologica, ma anche l’avere una relazione di coppia stabile influisce in modo significativo.
Oggi si può davvero pianificare e decidere, quando è il momento giusto per mettere al mondo un figlio. Stabilità affettiva, sicurezza economica, realizzazione professionale, sono quelle certezze che si cerca di raggiungere prima di decidere di metter al mondo un figlio oggi. Tutto ciò contribuisce a rendere la maternità e la paternità sempre più delle scelte consapevoli.
Stiamo parlando quindi di una possibilità di scelta ponderata, che arriva a maturare nella coppia generalmente quando ci sono obiettivi ed esigenze condivise, quindi si desidera mettere al mondo un bambino per accedere ad una dimensione più intima del rapporto, per percepirsi come coppia adulta.
La possibilità di decidere quando avere un figlio porta ad enfatizzare molto il momento della scelta, rendendola estremamente ponderata e razionale. Il desiderio di un figlio però non può sempre sottostare alla logica della ragione, perché è qualcosa di troppo forte, di istintivo, passionale e può anche far irruzione nella vita di coppia nel momento meno opportuno, nel quale non c’è stabilità economica, magari quando c’è in vista un cambiamento importante di lavoro. Sono momenti della vita che sembrerebbero i meno adatti all’arrivo di un figlio però magari coincidono con una fase del rapporto di coppia in cui si fa più forte il desiderio di avere un bambino e diventare genitori.
La nascita di un figlio è una delle fasi principali del ciclo di vita di un individuo e come tutti i passaggi da una fase all’altra del ciclo di vita individuale e familiare rappresenta un evento critico che porta la famiglia a riorganizzarsi al suo interno per favorire il cambiamento. Le crisi che accompagnano questi passaggi evolutivi sono sane e positive nella misura in cui favoriscono la crescita psicologica e sociale degli individui, negative se la famiglia non riesce a riorganizzarsi.
La conflittualità che inevitabilmente accompagna ogni momento di crescita da una fase dello sviluppo ad una più matura, diventa negativa quando temuta e non ammessa, non riconosciuta, quindi negata e repressa.
Da due a tre: le aspettative…la realtà
La nascita di un bambino è un piccolo grande evento, sempre unico che comporta una vera e propria tempesta di emozioni: dubbi, problemi, felicità, preoccupazioni.
Quando una coppia decide di avere un figlio è euforica ma allo stesso tempo un istante dopo il momento di entusiasmo ognuno dei due partner in genere si sofferma a valutare con maggiore oggettività gli effetti che questa decisione comporta.
Cominciano a pensare che dovranno modificare le loro abitudini, riorganizzare tempi e modi, gli spazi della loro vita a due, rinegoziare i compiti e gli accordi perché l’obiettivo deve essere quello di garantire alla creatura che verrà una vita serena.
Una difficoltà tipica di questa fase è l’ambivalenza tra il desiderio e allo stesso tempo la paura di diventare adulti.
Il lavoro che dovrà affrontare la coppia in questa fase ed in funzione del nuovo ruolo, sarà quello di ri-pensarsi individualmente, ri-considerare il compagno, ri-considerare la loro relazione.
L’ambivalenza presente in questa fase si esprime quindi con sentimenti di desiderio e rifiuto, di gioia ma anche di timore, di entusiasmo e preoccupazione che possono coesistere. Questo continuo oscillare in maniera ambivalente tra sentimenti opposti è una condizione naturale che talvolta crea sensi di colpa che bisogna imparare a gestire.
In questa fase, insieme al desiderio di diventare genitori, nascono anche un insieme di pensieri, di aspettative e desideri, di dubbi, tanti dubbi che devono essere sorretti da un ambiente supportivo altrimenti rischiano di alimentare ansie rispetto al ruolo genitoriale.
I dubbi più ricorrenti, in particolare per le donne sono: come sarò con mio figlio? Sarò i grado di educarlo? Sarà sano? Riuscirò ad essere una buona madre?
Quando una coppia si accorge di aspettare un figlio, in particolar modo il primo, inizia a ricercare delle risposte ai numerosi dubbi su ciò che accadrà quando nascerà il bambino, su come cambierà la loro vita, ricercano rassicurazioni sul comportamento da avere, sul loro ruolo, cominciano a domandarsi come si concretizzerà il loro aiuto reciproco, quale carico di cure spetterà a ciascuno, quali nuove responsabilità si dovranno assumere.
Ciò che si fa in questi casi generalmente è chiedere consigli ai genitori o iniziare a “studiare” libri e manuali che parlano di gravidanza e di preparazione alla vita in tre.
Il più delle volte questi testi divulgativi danno delle indicazioni pratiche rispetto alla cura del bambino, sul come preparare la sua cameretta, una sorta di manuali che insegnano ad essere “genitori perfetti”.
Ma il loro limite sta proprio nel non considerare l’impatto che hanno i cambiamenti relazionali ed affettivi all’interno di una coppia.
Un bambino prima di essere concepito ed entrare a far parte del mondo, viene pensato, poi immaginato. Questa immagine accompagnerà la coppia per i nove mesi della gravidanza.
Molte persone vengono colte alla sprovvista dalla grandezza di questa sfida, il modo migliore per prepararsi è cercare di coniugare la gioia e l’entusiasmo per la nascita con delle aspettative che siano realistiche.
Se un figlio arriva in una coppia che non ha precedentemente consolidato la propria identità di coppia (che si raggiunge anche attraverso la separazione emotiva rispetto alla famiglia d’origine), creerà uno squilibrio complicato da gestire, soprattutto quando la coppia è troppo giovane o psicologicamente impreparata.
Il lavoro di preparazione che la coppia è chiamata a fare, se necessario anche attraverso il supporto di uno psicologo, è quello di allargare lo spazio relazionale sia fisico che emotivo passando da una relazione bidimensionale ad una tridimensionale.
Quando il futuro papà tocca la pancia, inizia a parlare al bambino in grembo, sta già iniziando a costruire un rapporto ed uno spazio relazionale a tre. Oggi i padri, a differenza dei modelli culturali del passato, vogliono esserci sin da subito.
Oltre alla coppia, anche la generazione precedente può nutrire forti aspettative: l’aspettativa di diventare nonni, l’aspettativa di sentirsi utili nella vita dei neo genitori, di avere una discendenza, di avere di nuovo potere sui propri figli che si ritroveranno probabilmente a chiedere loro aiuto.
Tutti questi vissuti che ruotano attorno alla coppia possono creare tensione oltre alla coppia anche al sistema familiare allargato. Le attese dei propri genitori potrebbero trasformarsi in pressioni.
Il post-partum
Il periodo successivo al parto è un momento di profonda fragilità emotiva per la neo-mamma, solo per il fatto di essere genitore di quell’esserino complicatissimo dobbiamo sapere come funziona e se non ci riusciamo subentra un profondo senso di inadeguatezza.
Generalmente la Tentata Soluzione tipica che una neo mamma mette in atto è quella di richiedere continuamente, talvolta in maniera ossessiva, rassicurazioni e pareri, all’esperto di turno o a familiari o amici i quali con le migliori intenzioni ovviamente, ma finiranno per svalutarla.
Il rientro a casa dall’ospedale è un momento davvero critico per la coppia, è una tappa significativa della transazione alla genitorialità, anche simbolicamente rappresenta il passaggio da coppia a famiglia.
Si rientra in una casa, quella coniugale, nella quale fino a quel momento si era vissuto in due ed ora tutto deve essere ristrutturato in funzione della triade.
E poi c’è questo esserino, che polarizza su di sé le attenzioni di tutti.
I ritmi familiari, le abitudini, sono tutte modificate e riadattate in funzione del bambino.
La sensazione spesso avvertita è la mancanza di punti di riferimento, di coordinate, di inesperienza, di smarrimento a volte.
Questa fase, il post-partum è un periodo estremamente difficile soprattutto per la mamma.
Subentrano malinconia e tristezza, essenzialmente per ragioni sia psicologiche che biologiche e talvolta la preoccupazione di non sapere esattamente come agire nei confronti di quest’esserino determinando una sorta di paralisi ad agire che può incrementare ancora di più il sentimento di inadeguatezza.
A livello biologico nel post-partum accade che il livello di estrogeni nel sangue si riduca drasticamente provocando un fisiologico calo del tono dell’umore, che quasi sempre si accompagna ad un calo del desiderio sessuale. Chiaramente la vita di coppia risente di tutto questo in maniera significativa.
La discrepanza tra le aspettative del diventare genitore e ciò che si verifica poi nella realtà quotidiana può essere causa di destabilizzazione e profonde incomprensioni per la coppia.
Una buona strategia è dedicare il periodo dell’attesa e quindi la gravidanza, a rinsaldare il legame di coppia, condividendo le reciproche aspettative sulla nascita del bambino, il proprio immaginare sul diventare genitori, provare ad immaginare insieme un piano strategico per affrontare al meglio i cambiamenti che avverranno.
Una delle più grandi difficoltà alla quale va incontro un genitore è sostituire un suo modo di vivere per far posto ad un nuovo adattamento.
Un figlio costringe a ridefinire la propria identità in modo così profondo da provocare confusione nei neo genitori rispetto al loro nuovo ruolo.
Il ruolo del papà
Alcuni studi segnalano come in particolare gli uomini abbiano maggiore difficoltà rispetto alle nuove responsabilità proprio perché a differenza delle donne, non hanno un ruolo ben definito e determinante.
Da una parte si trovano a confrontarsi con un modello tradizionale in cui l’uomo è sempre rimasto fuori, fuori dalla camera quando il parto avveniva in casa o fuori dalla sala parto dell’ospedale, fuori dall’ambulatorio pediatrico o dai primi giochi del bambino.
Da allora l’uomo ha attraversato un cambiamento profondo delle sue radici culturali, del suo modo di porsi anche a livello psichico nei confronti della donna e del bimbo.
Oggi nell’uomo il periodo della gravidanza e del dopo parto può creare maggiori insicurezze, può essere messa in crisi la sua identità personale e talvolta come Tentata Soluzione l’uomo può in questi casi investire magari di più sul lavoro, con la motivazione che aumentano le esigenze economiche.
Questa Tentata Soluzione, potrebbe, da un lato confermarlo nel suo ruolo di genere e consentirgli di tenere sotto controllo le ansie che si scatenano durante il periodo dell’attesa, d’altro canto inizia a segnare una distanza con la partner.
I padri talvolta, hanno la tendenza ad interpretare le loro responsabilità più sul piano economico, sul dover fornire alla famiglia tutto il necessario e quest’atteggiamento si accentua ancor di più dopo la nascita del bambino e può avere delle ripercussioni sul benessere psicologico individuale e della coppia.
Nei primi mesi del bambino si può accentuare nel padre il peso della responsabilità di dover provvedere economicamente alla famiglia, questa pressione che avverte può anche influenzare il suo stile genitoriale ed il suo coinvolgimento nella vita del bambino.
Anche l’uomo quindi, va incontro ad una serie di cambiamenti e talvolta difficoltà con la paternità ed anche l’uomo può aver bisogno di essere sostenuto in questo momento di ridefinizione di sé, con tutte le paure che lo accompagnano: paura del cambiamento, della responsabilità, gelosie nei confronti della compagna, l’assunzione di un nuovo ruolo che lo porta a lasciarsi alle spalle la leggerezza della giovane età.
I cambiamenti nella relazione
Oliviero Ferraris sostiene che “diventare genitori incide sul rapporto di coppia: ne fa parte come qualcosa di integrante e dirompente, lo salda o lo scardina secondo come il rapporto è stato strutturato in precedenza”.
Quante volte per scherzare abbiamo detto o sentito dire “usciti dall’ospedale si sono dimenticati di darci il libretto delle istruzioni”.
La nascita di un figlio comporta una trasformazione e ristrutturazione della famiglia, i partner oltre al ruolo coniugale devono assumere anche quello genitoriale.
In casa si contrae fisicamente lo spazio abitativo, aumentano i bisogni, si scatena una rivoluzione di regole e la coppia si trova “costretta” ad aprire i confini per il nuovo nato.
Tutto questo comporta necessariamente una ridefinizione della relazione tra i partner, non sono più solo compagni ora sono anche genitori.
Proprio i primi mesi da genitori sono percepiti come il più grosso scoglio per la relazione.
Solo ad una minoranza riesce facile accettare il ruolo di padre e di madre senza in questo trascurare il ruolo di partner.
E’ per questo che i primi mesi di vita del bambino i neo genitori hanno la sensazione che la loro vicinanza vada dissolvendosi. Intimità, affettuosità, comprensione reciproca vengono meno e prende il sopravvento la cura del bambino.
Molti genitori arrivano alla falsa conclusione che il relegare in secondo piano in maniera temporanea la relazione di coppia in favore delle cure genitoriali, sia un bene per il neonato perché così a lui può andare tutta l’attenzione che altrimenti verrebbe data al partner.
In realtà accade l’esatto contrario, ovvero il reale benessere del bambino si sposa con l’armonia di una coppia genitoriale in grado di scambiarsi affettuosità e attenzioni ritagliandosi i propri momenti e i propri spazi. Un bambino sente l’amore o la distanza tra i suoi genitori.
Diventare genitori significa affrontare una costellazione di cambiamenti che riguardano se stessi, la coppia, la famiglia d’origine.
- Per quanto riguarda il rapporto con se stessi: emergono nuove responsabilità. Questa nuova piccola vita dipende solo da noi.
- Il rapporto di coppia. Possiamo dire che cambia completamente pelle, da diadico diventa triadico. Lo spazio relazionale di coppia viene arricchito da un terzo, questo terzo determina l’assunzione di un nuovo ruolo da parte di entrambi, quello di padre e quello di madre.
La cura di un figlio, soprattutto piccolo, necessita di tempi che prima la coppia dedicava a se stessa e al proprio tempo libero. Era il tempo per stare insieme, per divertirsi o rilassarsi, per vivere la propria intimità. Dopo l’arrivo di un figlio, questo tempo si riduce drasticamente.
Il rapporto di coppia diventa inevitabilmente più articolato e complesso, e inizia a muoversi lungo due direttrici: quella coniugale e quella genitoriale. - I cambiamenti investono anche la famiglia d’origine: vanno rimodulati gli assetti delle relazioni, non si è più solo figli ma anche genitori. E i propri genitori sono non più solo genitori ma anche nonni.
La donna è investita dai cambiamenti più evidenti, primi tra tutti quelli fisici, la totale trasformazione del proprio corpo richiede una riformulazione della propria immagine e della propria femminilità.
Nei nove mesi di gravidanza la donna ha il tempo necessario per strutturare una nuova immagine di sé che comprenda il ruolo di madre, quello di moglie, di compagna e di donna. La capacità dell’uomo deve essere quella di sostenere in questo momento così delicato la propria compagna accettandone le debolezze che manifesta.
Anche l’uomo è investito da grandi cambiamenti. Per lui l’attesa di un figlio porta emozioni molto forti: timore per lo sconosciuto e preoccupazione per le responsabilità.
Il nuovo equilibrio
Compito della coppia è quindi dover trovare un nuovo equilibrio, diverso dal precedente e riadattarsi per passare da una relazione a due ad una relazione a tre.
L’equilibrio in una coppia è un concetto molto complesso che dipende da tanti fattori: contestuali, personali, relazionali etc ed è strettamente collegato alla variabile NOI (energie messe in campo dalla coppia) più che la variabile IO (energie messe in campo dal singolo individuo)
Ogni nascita è un evento che inevitabilmente va a modificare l’equilibrio precedente e porta con sé profondi cambiamenti: un cambiamento quindi di ruolo se si aspetta il primo figlio, di riposizionamento dei membri all’interno della famiglia.
L’equilibrio per definizione è un moto di continua oscillazione, una naturale fluttuazione necessaria per il riassestamento continuo del corpo nello spazio e allo stesso modo nelle relazioni di coppia la ricerca dell’equilibrio prevede una costante riorganizzazione in funzione degli ostacoli incontrati.
La stabilità del legame consiste in questo continuo riadattamento.
Affinchè ciò sia possibile occorre flessibilità di ruoli che consente alla coppia nonostante la difficoltà del momento, di funzionare in modo efficace affinchè le forze e i contributi dei partner si compensino intercambiandosi.
Il concetto di stabilità di coppia quindi in realtà è un concetto dinamico nel senso che prevede una alternanza di ruoli intercambiabili. Per far questo occorre che i membri della coppia siano sempre attenti a monitorare la relazione in modo da adattare il proprio ruolo ai cambiamenti. Viceversa la rigidità dei ruoli conduce verso la staticità più che la stabilità e soprattutto verso una distanza sempre più difficile da colmare.
Ad esempio quando c’è rigidità dei ruoli la coppia potrebbe iniziare a pensare che c’è sempre uno dei due che è quello più forte o affidabile o bisognoso. Imprigionarsi in queste etichette è poco salutare per la coppia e per la persona, sono delle trappole che rischiano di soffocare e limitare l’espressione delle proprie esigenze e bisogni.
Accade spesso che molte donne, soprattutto durante il periodo in cui i bambini sono più piccoli, hanno la tendenza a relegare i partner a ruoli periferici, ricoprendo da sole il proprio ruolo materno.
Questo tipo di premessa può gettar le basi per un modello genitoriale che prevede una netta differenzazione dei ruoli, anche se magari non era l’esito finale che si intendeva raggiungere.
Il primo elemento che andrebbe considerato per una serena transizione alla genitorialità è che tutto ciò che ha a che fare con il nascituro dovrebbe essere frutto di un lavoro di squadra. A prescindere da come poi si decida di suddividere concretamente i compiti nel quotidiano, la chiave consiste nel riflettere, dialogare e prendere congiuntamente le decisioni.
Ciò che le coppie in genere mi riferiscono è di avvertite la gravidanza e soprattutto i primi mesi che seguono il parto, come uno dei periodi più complessi della loro vita di coppia a causa dell’inevitabile interruzione della routine della famiglia. Il modo di relazionarsi con il partner che si riteneva acquisito e consolidato ora si dimostra inadeguato.
Ci sono nuove priorità, altre responsabilità. Diventare genitori scuote, modifica la percezione che si ha di sé, del proprio partner, della propria famiglia d’origine, dei propri amici, della propria vita.
La coppia che diventa madre e padre mette il bambino al centro e ciò produce una nuova struttura di rapporti. Molte coppie non riescono a gestire serenamente questo cambiamento.
Le attività che li accomunavano prima della nascita del bambino (cinema, teatro, cene fuori) ora sono complicate da realizzare anche perché i due neo genitori dormono molto meno, sono più nervosi e litigano più spesso a causa della stanchezza. Hanno rapporti intimi poco frequenti e comunicano meno.
L’entità del cambiamento che deriva dalla nascita del primo figlio non è vissuta in maniera identica dai due neo-genitori. Basti pensare che la maternità è vissuta dalla donna anche a livello corporeo, l’uomo non vive lo scombussolamento fisico che travolge la donna.
E’ proprio quella della sessualità una delle aree nelle quali c’è un grosso contraccolpo in termini di cambiamenti che accompagnano la nascita di un figlio che non viene quasi mai preso in considerazione dai testi divulgativi.
Può accadere che sin dalla gravidanza si verifichi un calo progressivo del desiderio. Durante i vari trimestri della gravidanza si verifica un mutamento del desiderio in base a mutamenti fisici ed ormonali.
La libido diminuisce nei primi tre mesi, poi risale nel secondo trimestre per l’aumento degli ormoni per poi ricadere nel terzo trimestre un po’ per l’evidente cambiamento fisico un po’ perché la donna comincia ad essere sempre più concentrata sull’imminente parto.
Alla nascita del bambino ciò che accade è che la donna si concentra esclusivamente sul bambino, come se perdesse interesse nei confronti di tutto ciò che è esterno. Questa diade madre-figlio e l’atteggiamento stesso della madre talvolta può scatenare sentimenti di esclusione da parte dell’uomo. Generalmente infatti in una coppia con figli piccoli, la madre si ritrova ad essere molto impegnata più o meno volontariamente, nell’accudimento del bambino e questa esclusività di relazione che si viene a creare tra madre e bambino, può condurre l’uomo a sentirsi trascurato, escluso, squalificato e in questo senso incidere negativamente sulla sua autostima.
Il periodo del post partum è quindi un momento molto delicato anche dal punto di vista della sessualità, per la maggior parte delle coppie. Dopo il parto la donna entra a pieno titolo nel suo ruolo di madre, deve abituarsi ai ritmi dell’allattamento e della cura del neonato, tentando di recuperare energie e disagi fisici e aspettando che il suo corpo ritorni alla condizione precedente la gravidanza. Tante donne già durante gli ultimi mesi della gravidanza cominciano a sentirsi a disagio rispetto ai cambiamenti che il proprio corpo ha subito.
I profondi cambiamenti che il suo corpo attraversa durante la gravidanza possono farla sentire meno attraente e piacevole per se e per il partner. Alcune donne hanno grosse difficoltà a conciliare l’immagine di mamma con quella di donna piacente e desiderabile questo ha l’effetto di un minore interesse verso l’intimità, in particolare i primi mesi dopo il parto.
Non tutti gli uomini riescono a condividere questo “aspettare”, con il rischio di chiudersi in se stessi, o viceversa di lamentarsi fin troppo palesemente pretendendo maggiore partecipazione dalla compagna. Accade spesso che le donne riprendano i rapporti sessuali, per non deludere magari anche se in realtà non si sentono ancora pronte per farlo. Anche in questi casi quando si cede non si fa altro che incrementare ansia e risentimento.
Il minore interesse sessuale può riguardare anche l’uomo a causa della sua difficoltà ad adattarsi ai ritmi del neonato (sonno interrotto continuamente), della gelosia nei confronti della diade madre-bambino o ad esempio perché può aver assistito alla sofferenza del travaglio e del parto.
Con la nascita di un bambino sicuramente la qualità di vita della coppia subisce una forte riduzione, in termini di attività piacevoli come lo stare insieme, parlarsi, ascoltarsi, fare l’amore, manifestarsi sentimenti affettuosi. Dopo la nascita del bambino si registra una diminuzione della soddisfazione di coppia anche perché il suo arrivo e la sua presenza rompe gli abituali schemi di risoluzione del conflitto che la coppia aveva precedentemente costruito nella vita a due.
Diciamo che nel periodo che segue il parto, le coppie vivono una serie di mutamenti fisiologici che sono caratteristici. Le coppie che ne sono a conoscenza avranno sicuramente minori difficoltà nel ricominciare a vivere la propria sessualità e far fronte alle insoddisfazioni che possono sopraggiungere nel rapporto di coppia, evitando così il cronicizzarsi di alcune dinamiche o conseguenze negative nell’accudimento del bambino.
Quando può insorgere il conflitto?
Il conflitto in una relazione di coppia può generarsi per diverse ragioni: un disaccordo rispetto allo stile educativo verso i figli, l’ingerenza della famiglia d’origine, la sessualità, la percezione che gli altri non rispettino i confini della coppia comportandosi in maniera giudicante o intrusiva.
Oppure ancora la percezione di non ricevere sostegno dal partner o che non si assume le proprie responsabilità nella gestione familiare.
La sensazione che l’intimità non sia qualitativamente e quantitativamente soddisfacente. Tutti questi aspetti, se non vengono tempestivamente e adeguatamente sollevati e condivisi tra i partner rischiano di produrre una insoddisfazione crescente che in genere non viene dichiarata direttamente ma resta in incubazione per emergere con prepotenza sotto altre forme, con altre modalità durante l’interazione quotidiana, ad esempio attraverso piccoli comportamenti ostili che maldispongono ancora di più il partner che si sentirà aggredito e si chiuderà difensivamente aggredendo a sua volta o rifiutando e incrementando sempre più l’escalation simmetrica del conflitto.
Qualche piccola strategia
Cosa è possibile fare affinchè questo delicato passaggio di vita possa costituire per la coppia un momento in cui ritrovarsi anziché perdersi? Non è un compito semplice, e non è semplice perché ciò che è realmente determinante in questo processo è l’equilibrio che la coppia aveva stabilito prima della nascita di un figlio.
E’ evidente che una coppia che funzionava già in maniera problematica prima dell’arrivo del figlio, rischia molto di più di una coppia che aveva raggiunto un buon funzionamento.
Cos’è che distingue una coppia “sana” da una che è in crisi?
Potremmo dire che la coppia sana è i grado di affrontare e superare la disillusione che segue normalmente la fase di illusione iniziale, in una coppia le promesse iniziali non possono essere mantenute tutte. Una coppia sana è in grado di rinegoziare i nuovi obiettivi e stabilire nuove aspettative con il tempo, dal momento che le persone cambiamo e quindi la coppia stessa.
La crisi e la sofferenza alla quale la coppia non riesce a far fronte e superare, vanno gestite attraverso l’aiuto di professionisti .
Quando il passaggio ad una fase del ciclo di vita così delicata come la genitorialità viene affrontata con maggiore difficoltà da uno dei due, l’altro membro, quello più forte può scegliere due direzioni: o continuare a camminare verso l’altro e magari con passi più decisi e veloci visto che si è reso conto che l’altro sta male, oppure fermarsi per stanchezza o perché non ritiene giusto dover fare il doppio delle fatiche per coprire le distanze.
Capita in una coppia che uno dei due sia fragile e quindi abbia bisogno di maggiore collaborazione e sostegno dal partner, l’importante è che sia per un periodo circoscritto altrimenti si ritorna al concetto di rigidità dei ruoli con una relazione sbilanciata e poco gratificante per entrambi.
Colui che chiede sempre aiuto potrebbe sperimentare un senso di inadeguatezza, chi fornisce sempre aiuto potrebbe sentirsi appesantito da questa funzione a senso unico
E’ importante che, terminati questi momenti circoscritti i ruoli si riallineino nuovamente.
- E’ fondamentale che la coppia sappia chiedere aiuto: quando il peso dei problemi, delle difficoltà quotidiane, diventa insostenibile è necessario allentare la tensione e lasciarsi aiutare. Chiedere aiuto però non è sempre facile. A volte la coppia ritiene di dovercela fare da sola a gestire il proprio bambino e sente che il chiedere aiuto rappresenti una sorta di piccolo fallimento.
Oppure la coppia può temere di essere di peso chiedendo aiuto. In tutti questi modi si priva della possibilità di scoprire che in realtà genitori, amici, parenti, il più delle volte sono ben contenti di rendersi utili.
Il supporto emotivo e materiale della rete sociale e dei familiari è di vitale importanza per il benessere della coppia e dell’individuo in una fase così delicata.
Il sostegno, in generale, ha una funzione protettiva indipendentemente dal presentarsi o meno di eventi stressanti, allo stesso modo la mancanza di relazioni di supporto sarebbero preliminari al costituirsi di condizioni di rischio che possono trasformarsi poi in situazioni patogene. Numerose ricerche hanno confermato come alti livelli di supporto familiare e la self efficacy materna, ovvero la sensazione e la capacità di poter esercitare un certo controllo sugli eventi che riguardano la propria vita, siano associati a bassi livelli di sintomi di depressione post-partum nella donna.
Il sostegno emotivo alla neo coppia di genitori comprende comportamenti di ascolto, manifestazione di amore, di interesse ed incoraggiamento.
Poi c’è il sostegno tangibile, quello dato per risolvere questioni di ordine pratico. Questo è il tipo di sostegno che può ridurre lo stress perché risolve direttamente il problema o riduce l’onere fisico o psicologico.
Sono tanti gli autori che concordano sul fatto che le donne che non hanno una adeguata rete di supporto e si ritengono insoddisfatte del sostegno che hanno ricevuto in gravidanza sono maggiormente a rischio di sviluppare una sintomatologia depressiva, sia durante la gravidanza che 6/8 settimane dopo il parto.
Una sintomatologia depressiva della donna può produrre una reazione depressiva anche nell’uomo. Un genitore sotto stress non è in grado di essere di supporto per il partner durante il periodo post natale, ciò porta ad una insoddisfazione coniugale che può persistere ed incrementare durante tutto il primo anno di vita del bambino. In questo caso individuare precocemente le famiglie a rischio ed aiutare le coppie durante la transazione alla genitorialità, diventa una priorità nei trattamenti di prevenzione.
Il processo di adattamento da parte della coppia ai nuovi ritmi richiede tempo anche perché c’è la sensazione costante di inesperienza, di impreparazione che i genitori avvertono.
Tutto ciò richiede tempo e solidarietà non solo all’interno della coppia ma anche da parte della rete di rapporti significativi. La famiglia estesa ha un ruolo significativo nel modulare gli effetti dello stress. Utilizzare un appoggio sia emotivo che partico da parte della famiglia d’origine, degli amici, dei parenti, rappresenta un valido aiuto nella gestione dello stress durante i momenti di massima vulnerabilità che una coppia di neo-genitori attraversa.
Con l’arrivo del bambino i rapporti tra i neo genitori e le rispettive famiglie d’origine subiscono un profondo mutamento. La neo copia di genitori può contare non solo sul sostegno emotivo e affettivo ma anche materiale e pratico. I contatti con la famiglia d’origine si intensificano, i neo genitori sentendosi più adulti con la nascita del figlio si rapporteranno con le proprie figure genitoriali meno in qualità di figli e più in veste di uomo e donna. - Riuscire a trascorrere del tempo libero in attività ricreative con i propri amici, può ridurre lo stress perché risponde al bisogno di aggregazione e di contatto sociale, aiuta le persone a distrarsi dalle preoccupazione e aumenta il buon umore.
Talvolta può verificarsi che la coppia, per diverse ragioni, tenda a sottrarsi all’influenza dei propri genitori, investendo in una rete di legami significativi con persone della loro stessa età, alle quali la coppia potrà rivolgere le proprie esigenze di intimità, guida. Gli amici in questo caso possono entrare a far parte della rete familiare come se facessero parte della stessa famiglia. Anche perché oggi i nuclei familiari sono sempre più ristretti e il sostegno interno alla famiglia è sempre più carente. La coppia quindi può e deve, in questi casi, cercare sostegno al di fuori della rete familiare tradizionale. - La programmazione serale condivisa: con l’obiettivo di suddividersi i compiti/responsabilità per il giorno successivo nelle diverse attività per evitare di ritrovarsi successivamente a discutere o recriminare. In questo modo si evita che uno dei partner abbia la sensazione che i compiti siano gestiti in maniera impari o uno dei due non si sente coinvolto nelle attività di cui si occupa l’altro.
Questo contribuisce a costruire un forte senso di reciprocità, è un momento ed uno spazio di condivisione della coppia, è uno spazio nel quale il bambino non c’è o è nello sfondo 8si fa quando il bimbo va a nanna) e da questo momento di organizzazione pratica e gestionale la coppia in maniera spontanea e naturale può anche costruire sopra altro, quindi comunicare, condividere, rilassarsi insieme e scambiarsi affetto. La programmazione delle attività aiuta a programmare anche il tempo da trascorrere insieme.
Per trovare il modo di trascorrere del tempo insieme la coppia ha bisogno di mettere in campo tutta la propria creatività. E’ necessario organizzare dei momenti, almeno un giorno la settimana che diventa il giorno della coppia, con il supporto della rete familiare e amicale, in cui poter vivere il rapporto di coppia liberamente (cena, passeggiata) senza in quel momento le responsabilità genitoriali e soprattutto senza parlare di quelle perché si sta godendo di un momento esclusivo della coppia.
Se il bimbo è ancora troppo piccolo e si ha qualche difficoltà a lasciarlo con altre persone o non ci sono, si può comunque programmare una cena speciale o un dvd da vedere a casa, dopo aver messo a letto il bambino.
L’importante è incorniciare quello spazio fatto di piccole cose piacevoli, come spazio della coppia e non di genitori. Anche pochi minuti “rubati” per la coppia ogni giorno, saranno un dono prezioso per il benessere della nuova famiglia. - Ritagliarsi dei momenti piacevoli come famiglia, è altrettanto importante. Spesso le incombenze quotidiane e la stanchezza ci fanno perdere di vista che in realtà è bello essere in tre. Soprattutto il fine settimana, bisognerebbe organizzare piccole cose piacevoli, passeggiate, gite. Paradossalmente nei primi mesi di vita del bambino è molto più semplice di quanto non potrà essere dopo. Questa sana abitudine contribuisce tra l’altro a dare la sensazione di “normalità” in una organizzazione familiare che inevitabilmente è più tumultuosa e caotica.
Se si è così bravi da riuscire a ritagliarsi con un po’ di creatività questi spazi a due, dietro l’angolo spesso si potrebbero nascondere i fantasmi dei sensi di colpa, pronti a rovinare la serenità del momento a due. Soprattutto le mamme, ma anche i padri, si sentono in colpa per aver escluso il piccolo. La coppia in questi casi va accompagnata a comprendere che è sano ed utile per tutti che i partner riescano a ritagliarsi degli spazi di coppia per ricaricarsi ed allentare le tensioni che il nuovo arrivato e le responsabilità comportano. Il rischio altrimenti è che il nuovo ruolo genitoriale prenda il sopravvento su tutto il resto.
Coltivare il benessere della coppia rimarrà sempre il fondamento della famiglia